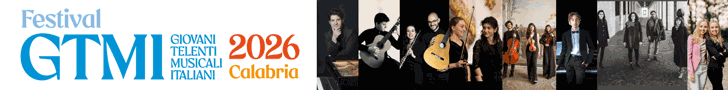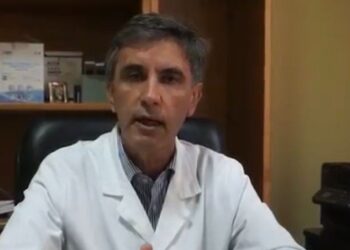Piccoli imprenditori, nuove iniziative giovanili, associazioni culturali e realtà locali stanno cercando di cambiare rotta, puntando sulla qualità, sull’autenticità e sulla sostenibilità
Con l’arrivo dell’estate, le spiagge calabresi iniziano a popolarsi di turisti, attratti da un patrimonio naturalistico unico, un mare cristallino e una tradizione enogastronomica d’eccellenza. Eppure, come ogni anno, la Calabria si presenta al grande appuntamento con la stagione estiva con ritardi, carenze strutturali e una generale sensazione di impreparazione. Una situazione che non solo penalizza l’immagine della regione, ma rischia di compromettere lo sviluppo di uno dei settori chiave per l’economia locale: il turismo.
La Calabria vanta 800 chilometri di costa, borghi storici incastonati tra montagne e colline, siti archeologici di rilievo, parchi nazionali e una biodiversità invidiabile. Tuttavia, queste risorse vengono troppo spesso valorizzate in modo frammentario o sporadico. A mancare è una visione strategica, integrata e di lungo periodo che trasformi il turismo in una leva di crescita stabile.
La regione continua a promuoversi come “terra autentica” e “scrigno di natura incontaminata”, ma la realtà – sul campo – è ben più contraddittoria: infrastrutture carenti, politiche ambientali inconsistenti e un modello economico che sembra ignorare le basi stesse della sostenibilità.
Uno dei principali ostacoli allo sviluppo turistico calabrese è rappresentato dalle infrastrutture. Le strade, soprattutto nelle aree interne, versano in condizioni precarie, mentre la rete ferroviaria è obsoleta e mal collegata. Gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, pur essendo fondamentali per il flusso di visitatori, non sono sempre supportati da servizi di trasporto efficienti verso le località turistiche. Per un turista straniero, raggiungere la Calabria può risultare complicato e scoraggiante.
Uno dei nodi più critici resta l’accessibilità. Mentre il turismo sostenibile richiede reti intermodali efficienti e alternative all’auto privata, la Calabria continua a scontare un isolamento infrastrutturale cronico. L’Alta Velocità si ferma a Salerno, le linee ferroviarie regionali – da Catanzaro a Cosenza, da Reggio Calabria a Sibari – sono lente, poco frequenti e spesso inaffidabili. I collegamenti interni sono ancora oggi dipendenti da strade statali logore e da un trasporto pubblico quasi assente nelle aree rurali.
Questo rende quasi impossibile valorizzare l’entroterra, proprio laddove esiste il maggior potenziale per un turismo lento, esperienziale, a basso impatto. Borghi abbandonati, aree protette come la Sila e il Pollino, cammini storici e vie naturalistiche restano fuori dai radar dei flussi turistici, malgrado gli sforzi compiuto nell’ultimo periodo da realtà innovative e propositive come si stanno dimostrando le iniziative adottate dal Parco delle Serre, oppure – ed ancora più concretamente – quanto fatto in poco tempo dalla nuova gestione dell’Ente Parchi Marini con l’adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, un percorso ambizioso e strategico, da realizzare attraverso uno strumento riconosciuto a livello internazionale che promuove la valorizzazione delle aree protette attraverso un turismo rispettoso dell’ambiente, delle comunità e delle economie locali.
Ancora, però, molte località balneari calabresi si animano solo durante l’alta stagione, ma per il resto dell’anno risultano quasi spente, con attività chiuse e scarsa offerta di servizi. Mancano piani di accoglienza coordinati, info point multilingue, itinerari culturali ben segnalati e, soprattutto, personale formato in modo professionale. Anche la digitalizzazione del settore è ancora indietro rispetto ad altre regioni italiane: pochi portali aggiornati, scarsa presenza social, prenotazioni online complicate o assenti.
A mancare, però, non sono solo le infrastrutture. È l’intero approccio alla gestione del territorio a essere ancora inadeguato. L’abusivismo edilizio – mai davvero contrastato – continua a deturpare tratti di costa che dovrebbero essere tutelati. La raccolta differenziata è ancora disomogenea tra comuni e spesso inefficace. Le spiagge libere, pur rappresentando un bene comune prezioso, non sempre sono pulite o accessibili, e in alcuni casi diventano vere e proprie discariche stagionali.
Nel 2025, con un turismo internazionale sempre più orientato a criteri ESG (ambientali, sociali e di governance), la Calabria non può permettersi queste lacune. I viaggiatori cercano destinazioni in grado di garantire autenticità, ma anche trasparenza e impegno ambientale. E invece, a fronte di un patrimonio naturale straordinario, manca ancora un sistema di certificazioni ambientali, una rete regionale di eco-hotel, o un piano di gestione dei flussi turistici che tenga conto della capacità di carico dei luoghi.
Un altro fattore che rallenta la piena valorizzazione del turismo in Calabria è la burocrazia. Bandi e fondi europei vengono talvolta sprecati o restituiti per incapacità gestionale, mentre iniziative private vengono frenate da iter autorizzativi lunghi e farraginosi. A questo si aggiunge una scarsa sinergia tra enti pubblici, operatori del settore e comunità locali.
Non tutto, però, è negativo. Esistono esempi virtuosi: piccoli imprenditori, nuove iniziative giovanili, associazioni culturali e realtà locali che stanno cercando di cambiare rotta, puntando sulla qualità, sull’autenticità e sulla sostenibilità. Il problema è che queste esperienze restano spesso isolate e non riescono a fare sistema. Per uscire da questa impasse, serve un cambiamento culturale profondo, che metta al centro il turismo come bene comune e investimento sul futuro.
Il cambiamento non è impossibile. Esistono esperienze virtuose, anche in Calabria, che possono diventare modelli da replicare:
- Promozione di borghi sostenibili: investire in piccoli comuni dell’entroterra per creare micro-hub turistici con ospitalità diffusa, turismo rurale e agriturismo biologico. San Giovanni in Fiore, Badolato o Morano Calabro hanno già sperimentato pratiche in questa direzione, ma servono risorse strutturali e una rete regionale coordinata.
- Mobilità integrata e verde: creare collegamenti in bus elettrici tra stazioni ferroviarie principali e località turistiche interne, incentivando il noleggio di bici elettriche e car sharing. L’adozione di un “Calabria Green Pass” con accessi integrati a trasporti e attrazioni locali potrebbe essere un incentivo forte.
- Gestione partecipata dei parchi naturali: coinvolgere cooperative di giovani e associazioni ambientaliste nella cura dei sentieri, nella guida ecoturistica e nella manutenzione del territorio. Una politica che crei lavoro locale e allo stesso tempo tutela ambientale.
- Educazione turistica locale: i residenti devono essere parte attiva del cambiamento. Campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione per operatori turistici e iniziative scolastiche possono diffondere la cultura della sostenibilità e della legalità.
Insomma, la Calabria, se vuole davvero entrare nel mercato del turismo sostenibile, deve superare l’approccio emergenziale e frammentario che da anni contraddistingue le politiche pubbliche regionali. È necessario un Piano Strategico per il Turismo Sostenibile, con obiettivi chiari, risorse vincolate e una cabina di regia unica, che coinvolga comuni, università, imprese e terzo settore. In assenza di una visione d’insieme, la Calabria rischia ancora una volta di rimanere spettatrice del proprio potenziale inespresso. E l’estate 2025 – come molte altre prima – passerà senza lasciare nulla di duraturo, se non un aumento di traffico, consumo di suolo e turismo occasionale. L’estate è arrivata, ma la Calabria – ancora una volta – non sembra essere pronta ad accoglierla come meriterebbe.
Solo così la Calabria potrà finalmente smettere di rincorrere l’estate e iniziare a viverla da protagonista.