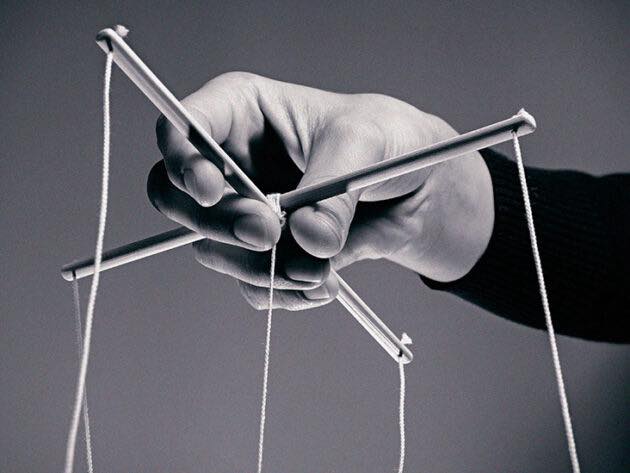A proposito dei dati forniti dalla Rete L’Abuso anche in Calabria, una analisi schietta proposta, in chiave psicologica, da un sacerdote che è innanzitutto un “uomo libero”
di Don Danilo D’Alessandro
Gli scandali che hanno scosso la Chiesa italiana sugli abusi perpetrati su minori, anche da parte di sacerdoti in Calabria, non sono soltanto notizie di cronaca: sono ferite aperte nella carne viva del Vangelo. Ogni volta che un presbitero tradisce la fiducia affidatagli, non crolla solo una figura individuale: si incrina un simbolo, una paternità, un volto di Dio che le persone cercavano nella Chiesa.
Di fronte agli abusi, serve verità, giustizia, denuncia. Ma serve anche intelligenza clinica e spirituale, capace di leggere le radici profonde di una patologia che non è solo morale, ma anche psichica e relazionale.
1. La personalità del presbitero: un terreno sacro e fragile
Essere sacerdote significa vivere costantemente dentro una tensione: tra l’umano e il divino, tra il bisogno di essere amato e la vocazione a donarsi.
Molti preti, nella loro formazione, vengono educati a “funzionare”, ma non sempre imparano a riconoscere le proprie emozioni, solitudini, ferite. La vita pastorale, spesso segnata da isolamento, aspettative eccessive e carenza di affetti autentici, può favorire meccanismi di compensazione: dipendenze, idealizzazioni, disordini affettivi, doppie vite.
Dal punto di vista clinico, si osservano talvolta tratti di personalità narcisistica o dipendente, che possono degenerare in comportamenti abusivi quando il soggetto non è capace di regolare i propri impulsi e gestire il potere spirituale che esercita.
Il punto non è giustificare: è comprendere che un prete ferito, non accompagnato e non sorvegliato, può diventare un rischio per sé e per gli altri.
2. Il potere spirituale come rischio psicopatologico
Ogni ministero comporta una forma di potere: quello di guidare, consigliare, confessare, benedire.
Quando questo potere non è temperato dall’umiltà e dal controllo interiore, si trasforma in dominio, e il sacerdote smette di essere padre per diventare padrone.
In psichiatria si parla di “disturbo della personalità con tratti di grandiosità morale”, quando il soggetto si percepisce come strumento esclusivo di Dio, non più come servo inutile. È in questa distorsione che si aprono le crepe più pericolose.
L’abuso sessuale o spirituale nasce quasi sempre da una combinazione di fragilità narcisistica, isolamento affettivo e deresponsabilizzazione morale.
Chi abusa spesso non agisce per pura pulsione sessuale, ma per bisogno di controllo, potere e autoconferma. È la perversione del ruolo pastorale: il potere usato non per guarire, ma per possedere.
3. La comunità come contesto terapeutico e preventivo
L’abuso clericale non è mai solo “colpa di uno”. È anche fallimento di una comunità che non vede, non ascolta o non parla.
Le parrocchie, i seminari e le diocesi dovrebbero diventare luoghi di supervisione, di ascolto psicologico e di verifica costante del benessere emotivo dei sacerdoti.
Questo non è diffidenza, ma carità intelligente: la Chiesa deve imparare a fare prevenzione come un medico fa prevenzione delle malattie.
Le evidenze cliniche mostrano che:
• La supervisione periodica (psicologica e spirituale) riduce drasticamente i comportamenti a rischio.
• La vita fraterna e la condivisione sincera delle proprie fragilità rafforzano l’autocontrollo e la resilienza morale.
• La solitudine cronica e la mancanza di affetto reale sono fattori di rischio altissimi per deviazioni comportamentali.
La comunità cristiana può diventare un contesto terapeutico, se sa vigilare senza giudicare e sostenere senza coprire.
4. Il trauma delle vittime e la necessità della denuncia
Ogni abuso lascia cicatrici invisibili: ansia, insonnia, depressione, disturbo da stress post-traumatico, perdita di fiducia in sé e nella fede.
Il trauma è come una bomba silenziosa che esplode per anni, e spesso solo la parola restituisce libertà.
Ecco perché denunciare è un atto di guarigione.
Denunciare significa dire: “il male non avrà l’ultima parola”.
Denunciare significa rimettere Dio al centro, perché il silenzio complice è idolatria: è preferire l’immagine della Chiesa alla verità del Vangelo.
Chiunque sappia, veda o sospetti, ha il dovere di parlare. Non si tratta di screditare la Chiesa, ma di purificarla, perché la santità passa anche attraverso la giustizia.
5. Per una Chiesa che cura e non copre
Il sacerdote che abusa va rimosso, giudicato e curato. Ma soprattutto, va fermato subito.
La misericordia non è mai copertura del male: è verità che salva.
La Chiesa italiana, se vuole tornare credibile, deve creare centri di ascolto psicologico indipendenti, con professionisti laici e religiosi insieme, per accompagnare vittime e sacerdoti in percorsi separati ma convergenti nella verità.
Ogni vocazione è un terreno sacro. Ma il terreno va coltivato, non idolatrato.
Il prete non è un essere superiore, ma un uomo chiamato a portare un tesoro in vasi di creta. Quando questi vasi si incrinano, la risposta non è nasconderli, ma curarli, illuminarli, e impedire che diventino strumenti di distruzione.
Conclusione: la purificazione della Chiesa passerà attraverso la luce
È tempo di un nuovo coraggio: quello della verità, della denuncia, della trasparenza.
Un sacerdote sano psicologicamente è un dono per la comunità; un sacerdote malato e non accompagnato è un pericolo.
Solo una Chiesa che sceglie la luce invece dell’immagine, la cura invece del silenzio, la giustizia invece della paura, potrà tornare ad essere davvero casa, scuola, cortile e famiglia per tutti.