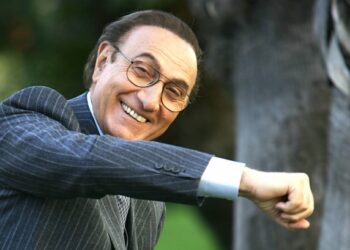Domattina, in occasione del Giubileo del Mondo della Comunicazione, come giornalisti saremo chiamati a riflettere su alcuni importanti valori. Intanto, si è fatto largo in me un primo ragionamento, ricordando sempre l’ammonimento di Anais Nin: “non vediamo le cose come sono… le vediamo come siamo noi”
di Maurizio Bonanno
Capita, a volte, che riaffiori qualche ricordo di gioventù. Ed è capitato anche a me di imbattermi in ricordi risalenti ai tempi del liceo. Riconosco di non essere stato uno studente modello, ma ricordo che tra i miei preferiti, durante le complicatissime lezioni di Greco, c’era certamente il poeta Archiloco (VII secolo a. C.). Sicuramente perché si presentava come una figura controcorrente, particolare che me lo rendeva simpatico perché piaceva identificarmi in lui: i caratteri fondamentali della sua poesia erano l’anticonformismo, l’individualismo, sapeva essere mordace e irriverente castigatore della morale comune e con il gusto della realtà in un senso pragmatico lontano dagli stereotipi eroici: un antieroe insomma.
C’è un verso di Archiloco che appare di incredibile attualità ripensando al nostro vivere oggi, qui, in questo strano mondo che è la nostra Vibo Valentia: «La volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una grande». Πολλ’ οἶδ’ ἀλώπηξ, ἀλλ’ ἐχῖνος ἕν μέγα.
Cosa voleva significare Archiloco?
Probabilmente che le volpi sono in genere più astute, flessibili e versatili in situazioni diverse, mentre i ricci, solidi nelle loro convinzioni, tendono ad affidarsi a regole ben definite.
Questa sorta di “favola in miniatura” trova il modo di contrapporre la superficialità all’approfondimento, la frivolezza alla costanza di attitudini e di interessi. Ed ha avuto un successo enorme, capace di attraversare ogni epoca. L’ha citata Erasmo da Rotterdam (quello dell’Elogio alla pazzia, altro libro da me amato), nella sua raccolta di motti Adagia, fino ad arrivare al XX secolo, quando nel 1953 il filosofo e storico inglese Isaiah Berlin (1909-1997) recupera questa antica favola di Archiloco nel suo testo The Hedgehog and the Fox. An Essay on Tolstoy’s View of History (pubblicato in Italia ne Il riccio e la volpe e altri saggi).
Berlin ne fa uso per “catalogare” alcuni fra i più grandi pensatori della storia, inserendoli per similitudine attitudinale entro le due specie animali in questione, ma la favola gode di buona salute anche nel nuovo millennio. Nel 2001 lo studioso americano di management Jim Collins la riprende a suo modo nel best-seller manageriale Good to Great. Qui volpe e riccio rappresentano due opposti modelli di percezione e “visione” legati alla sfera lavorativa. Secondo Collins, la volpe vive l’esperienza del mondo nella sua complessità, ma non riesce a integrare il suo agire in una visione unitaria. Al contrario, il riccio semplifica il mondo grazie a un’idea unificatrice in grado di guidarlo ai suoi traguardi.
Una più recente comparsa della favola di Archiloco la si trova in “Contro gli specialisti. La rivincita dell’umanesimo” (2013) di Giuliano da Empoli. In questo testo, il paradigma della volpe è assimilabile a quello di uno spirito generalista, capace di attraversare le frontiere della conoscenza per produrre idee nuove e inattese, mentre il riccio rappresenta l’ethos dello specialista, nel cui fallimento Da Empoli ritrova la principale causa della crisi economica e culturale di cui l’Occidente continua a essere vittima.
Nel mondo di oggi, costantemente inondati di informazioni (vere o false), sta diventando sempre più difficile discernere ciò che è affidabile e scegliere cosa leggere o guardare. Ed allora, è meglio essere un riccio che persegue caparbiamente un obiettivo o una volpe, capace di affrontare tante cose con il rischio, però, di non eccellere in nulla?
Ed ancora, è preferibile la forza centripeta dei ricci che riportano tutto a un sistema, più o meno coerente o articolato, attraverso il quale capiscono, pensano e sentono? Oppure, la forza centrifuga delle volpi, il cui pensiero è diffuso, si muove su diversi livelli, sfruttano l’essenza di una grande varietà di esperienze senza forzarle in una visione immutabile, omnicomprensiva, contraddittoria e talvolta incompleta, se non fanatica?
Chi sono, fra i tanti che incontriamo per la via, i ricci e chi le volpi?
E noi, cosa siamo?
Il riccio vede il mondo attraverso un’unica idea, una grande visione centrale, la volpe attinge, invece, ad una vasta gamma di esperienze e nei suoi ragionamenti è abile ad integrare prospettive e idee differenti. Il riccio non si agita mai, non dubita. La volpe è più pragmatica e più incline a vedere complessità e sfumature.
Daniel Kahneman psicologo israeliano, vincitore, insieme a Vernon Smith, del Premio Nobel per l’economia nel 2002, all’interno del suo celebre “Thinking, Fast and Slow”, vede i ricci quali rappresentanti di eventi particolari all’interno di un quadro coerente, irti di impazienza verso coloro che non vedono le cose a modo loro e sono fiduciosi nelle loro previsioni. Sono anche particolarmente riluttanti ad ammettere l’errore. Le volpi, al contrario, secondo Kahneman, sono pensatori complessi: non credono in un’unica grande visione, riconoscono che la realtà emerge dalle interazioni di molti diversi agenti e forze, inclusa la cieca fortuna, producendo spesso risultati grandi e imprevedibili.
Personalmente, ripensando ad Archiloco, mi rivedo più in una volpe, per quanto riconosca che c’è bisogno dei ricci che insegnino la disciplina e ad evitare distrazioni eccessive. Ma credo che la cultura racchiuda in sé i concetti di curiosità, di scoperta, di sperimentazione: insomma, un atteggiamento da volpe, che sembra essere l’unico modo per cercare di seguire ciò che accade in un mondo in continuo sviluppo.
Il solo talento del riccio sembra essere quello di raggomitolarsi e chiudersi ben serrato agli attacchi dietro la sua corolla di aculei: questa è “l’unica grande” tattica che conosce. Poca cosa di fronte alle molteplici iniziative della volpe, scaltra e sagace, che infatti, nella tradizione favolistica, quando rivaleggia col suo spinoso avversario, alla fine solitamente la spunta.
Insomma, riccio o volpe sembra la classica contrapposizione fra monisti (il riccio) e pluralisti (la volpe), non considerando che ogni formazione umana – la coppia, la famiglia, la squadra, il gruppo di lavoro – ha bisogno della combinazione di questi elementi: la fantasia e l’agilità della volpe, la precisione e la coerenza del riccio. Tanti ricci, insieme, diventano prevedibili, talvolta ossessivi; le volpi, da sole, rischiano di diventare dispersive e concludere poco.
Ma è possibile realizzare questa combinazione?
Al momento, purtroppo, appare solo un’utopia, perché intanto abbiamo a che fare con le peggiori conseguenze degli eccessi dell’uno e dell’altro e siamo qui a sperare che prima o poi ci si stanchi di questo scontro aspro, duro fino a diventare volgare, laddove non esiste più l’avversario con cui confrontarsi nel rispetto delle diverse idee e posizioni, ma solo un nemico da abbattere, un antagonista da sconfiggere e con il quale non è ammesso alcun tipo di collaborazione, neanche in nome del “bene comune”: un eccesso, un’esuberanza smisurata, un’esagerazione senza freni.
Come comportarsi, quindi?
Un suggerimento ci arriva proprio da Isaiah Berlin, quando non trova di meglio che rifugiarsi – ancora, un po’ disperatamente – nella Grecia antica e ricordare l’oracolo di Delfi quando ammoniva: “Non andate troppo oltre, non spingetevi troppo in là. Di nulla troppo”.