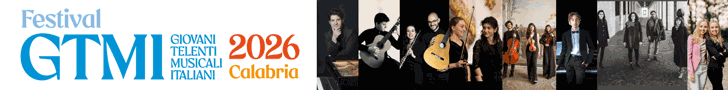Non è un referendum contro qualcuno. Non è una battaglia politica. È un referendum a favore della terzietà, del principio più nobile del nostro sistema democratico
di Antonello Talerico*
C’è una verità che oggi, più che mai, è necessario dire con chiarezza: la riforma sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri non è un atto politico, ma un atto di libertà giuridica. È un tassello indispensabile per completare quel percorso liberale che la Costituzione aveva aperto e che, come ha ricordato con fine lucidità Augusto Barbera, si è troppo spesso smarrito fra ideologie, convenienze e paure.
In sostanza questa riforma è necessaria per ridurre le ingiustizie. La magistratura non può essere indifferente – come lo è oggi – rispetto al pericolo di commettere errori, tanto non è sottoposta ad alcuna responsabilità per le proprie azioni, anzi lo è, ma se a giudicare il loro operato sono poi gli stessi magistrati e colleghi della stessa “corrente” chi mai verrà o potrà essere sanzionato?
Da parte di alcuni magistrati il rischio è che non ci sia alcuna attenzione piena e tensione nel decidere una causa penale o civile o amministrativa o nell’esercitare l’azione penale poiché comunque andrà non saranno tenuti a risponderne né a livello disciplinare, né a livello di avanzamento o meno di carriera. Anzi.
Del resto, se gli stessi magistrati oggi temono il “sorteggio” nella composizione dei nuovi organismi della Magistratura “separata”, vuol dire che essi stessi non si fidano dei propri colleghi.
Neanche i cittadini scelgono chi li dovrà giudicare o indagare poiché per Legge il giudice precostituito può essere qualsiasi magistrato, in quanto per Legge ogni magistrato dall’alto della sua funzione e prerogativa è in grado di poter giudicare secondo i canoni ed i principi costituzionali e di procedura.
Barbera, da giurista e da ex Presidente della Corte Costituzionale, ha ricordato come tutto parta dalla riforma Vassalli del 1987 e dal “giusto processo” dell’articolo 111 della Costituzione. Quella riforma — frutto di un equilibrio fragile ma lungimirante — conteneva già in sé la logica della separazione: un giudice terzo, in un contraddittorio tra parti in condizioni di parità. Ma quella parità è rimasta solo sulla carta, perché giudici e pubblici ministeri continuano a condividere carriere, logiche associative e, in parte, lo stesso organo di governo: il CSM.
Non è una questione di sfiducia nella magistratura. È una questione di garanzie costituzionali. Come ammoniva Piero Calamandrei — spesso evocato ma raramente letto per intero — la giustizia deve essere “visibilmente imparziale”, perché “non basta che il giudice sia giusto: deve anche apparire tale agli occhi dei cittadini”. Oggi quell’apparenza è offuscata.
Calamandrei, nella sua Relazione sul potere giudiziario del 1946, aveva già posto il problema centrale: come collegare la magistratura alla politica senza comprometterne l’indipendenza. La sua soluzione non fu quella di una magistratura autoreferenziale o corporativa, ma di un sistema in equilibrio tra autonomia e responsabilità. Non immaginò mai un corpo unico dove chi accusa e chi giudica appartengono alla stessa carriera e alle stesse correnti.
Ecco perché Barbera ha ragione: questa riforma è, prima di tutto, un passaggio di coerenza costituzionale. È la prosecuzione logica di quel cammino che parte da Vassalli e passa per Pera, fino ad approdare al principio liberale di separazione dei poteri.
Si può essere in disaccordo sul metodo, ma non sulla direzione. Chi oggi teme che la separazione delle carriere apra alla “subordinazione politica” ignora due fatti:
– primo, che la proposta di riforma affermerà con ancora maggiore forza l’autonomia e l’indipendenza della magistratura;
– secondo, che la vera dipendenza nasce quando le correnti giudiziarie si trasformano in fazioni interne capaci di condizionare nomine e destini professionali.
La Costituzione non ha mai voluto una “magistratura partito”, né un CSM che si comporti come un Parlamento parallelo. Ha voluto un ordine autonomo, responsabile e trasparente. Oggi è giunto il momento di restituire a quella visione la sua pienezza.
Calamandrei ci ricordava che la libertà “non si eredita, si conquista ogni giorno”.
Anche la libertà della giustizia va riconquistata, separando i ruoli, chiarendo i confini, restituendo al cittadino la certezza che il giudice e il pubblico ministero non siano — neppure simbolicamente — dalla stessa parte.
Non è un referendum contro qualcuno. È un referendum a favore della terzietà, cioè del principio più nobile del nostro sistema democratico. E questa, oggi, non è una battaglia politica.
È, come scrive Barbera, una battaglia liberale. È una battaglia di civiltà e di affermazione che tutti siamo eguali dinnanzi alla Legge. Anche i magistrati.
*Componente del Consiglio Nazionale Forense